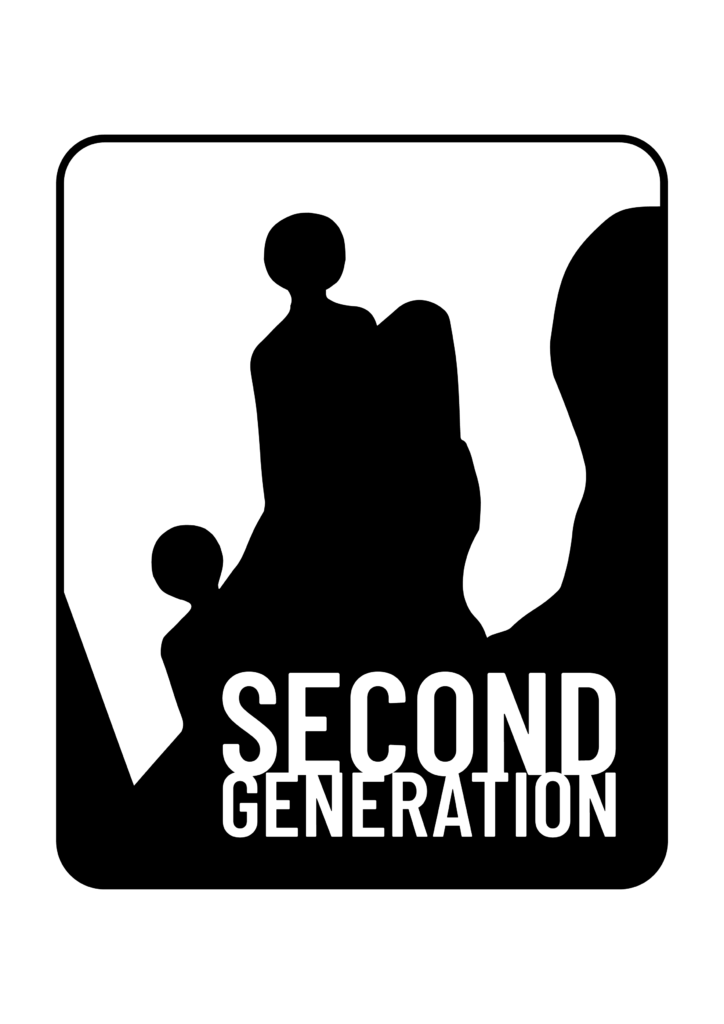
REPORT DI RICERCA DESK SUI MINORI E ADOLESCENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA NELLA CITTÀ DI VENEZIA E IN ITALIA.
Un mondo che attraversa il mondo. Il fenomeno sociale che sta trasformando la popolazione dei minori e degli adolascenti delle comunità urbane del nordItalia da identitare, italiane e monoculturali a identità culturali plurime, multietniche e multiculturali
La presenza degli adolescenti nel dibattito pubblico
Per scoprire che i minori e in particolare I minori e gli adolescenti entrano nel dibattito Pubblico nazionale e locale esclsusivamente per le problematiche di cui sono portatori, basta fare una veloce ricerca su google inserendo le parole chiave Adolescenti – Venezia. Sui circa 8.750.000 risultati ottenuti possiamo constatare che le tematiche più presenti e di maggior evidenza relative agli adolescenti riguardano l’aumento dei disturbi dei comportamenti alimentari, l’aumento e l’abbassamento dell’età negli esordi psicopatologici, l’ansia e l’autoisolamento da uso di tecnologie, l’autolesionismo e i suicidi, le baby gang; l’abuso di sostanze, il bullismo, la dispersione scolastica. Il mondo degli adulti sembra abbia relegato il mondo dell’adolescenza ad una questione prevalentemente sanitaria, di ordine pubblico e di marginalità sociale da governare attraverso politiche di cura sempre più specialistiche da parte del sistema sanitario, di contenimento e repressione dei reati da parte delle forze di polizia e del sistema giustizia, di selezione e di competizione nelle scuole. Di fatto, più che politiche rivolte al mondo dell’adolescenza, ci troviamo quasi sempre di fronte a risposte parziali che affrontano le problematiche adolescenziali in quanto emergenze sociali, mai di governo dei fenomeni sociali e delle loro trasformazioni. Interventi emergenziali che saltano le persone in quanto tali, in questo caso gli adolescenti, riducendoli alla problematica che evidenziano o di cui sono portatori.
Ma se questa è l’attenzione e il ruolo che il mondo degli adulti sembra assegnare ai minori e più in generale al mondo dell’adolescenza, nel frattempo in questi ultimi 18 anni, a causa delle profonde trasformazioni relative ai fenomeni migratori, la composizione della popolazione del territorio del Comune di Venezia (e della maggior parte dei centri urbani del nord Italia) in particolare quella in età scolastica 0 – 18 anni è strutturalmente cambiata. Le seconde generazioni, ovvero i figli nati in Italia da cittadini stranieri, i minori stranieri nati all’estero e giunti in Italia attraverso i ricongiungimenti familiari o come minori non accompagnati mediante i flussi delle migrazioni forzate, (e se a questi segmenti di popolazione ci aggiungiamo i minori cittadini italiani con identità culturale plurima come ad esempio i figli delle coppie miste o i minori presenti sul nostro territorio da adozioni internazionali), possiamo rilevare come si sia costituito un corpo sociale con un trend di crescita positivo non ancora esaurito tale per cui è possibile sostenere senza paura di essere smentiti, che la popolazione minorile con identità culturali plurime presente sul territorio della città di Venezia ha ormai un’incidenza tale sul totale della popolazione dei minori da averla trasformata da identitaria, italiana e monoculturale a multietnica e multiculturale.
Incidenza della popolazione straniera in Italia e nel Comune di Venezia
I dati riportati dal XIII Rapporto Annuale – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (2023)1 registrano che nel 2022 l’incidenza della popolazione straniera (5.030.716) sul totale della popolazione residente in Italia (53.599.417) è pari all’8,5%. Nel Comune di Venezia dai dati forniti dall’Amministrazione2, sempre per lo stesso periodo possiamo rilevare che l’incidenza della popolazione straniera (40.525) sul totale della popolazione residente nel Comune di Venezia (253.174) è pari al 16%, praticamente il doppio di quella rilevata a livello nazionale.
Popolazione straniera residente in Italia e nel Comune di Venezia
Sempre dallo stesso rapporto possiamo rilevare che tra il 2010 e il 2023, la popolazione residente in Italia si è ridotta di 840 mila unità (-1,4%), mentre nello stesso periodo la presenza straniera (+1,2 milioni di unità + 31,6%) ha compensato la costante riduzione della popolazione con cittadinanza italiana ( – 2 milioni di unità – 3,7%).
Se confrontiamo gli stessi dati nel Comune di Venezia, ma in un periodo più ampio (gli ultimi 18 anni), possiamo rilevare che la popolazione residente tra il 2004 e il 2022 si è ridotta di 18.498 unità (- 6,8%) passando dalle 271.663 (1 gennaio del 2004) alle 253.174 (31 dicembre del 2022). Nello stesso periodo la presenza straniera (+27.517 unità; +311,5%) dalle 13.008 presenze del 2004 è passataalle 40.525 del 2022. Anche in questo caso, la componente straniera ha in parte compensato la costante riduzione della popolazione veneziana ( – 46.006 unità; – 17,8%) passando dalle 258.655 persone del 2004 alle 212.649 del 2022.
Distribuzione della popolazione per età scolastica (0 – 18) nel Comune di Venezia periodo 2004 2022
Dalla guida ai Comuni, alle Province ed alle Regioni d’ItaliaTuttitalia.it con elaborazione dati Istat3, riscontriamo che negli ultimi 18 anni (2004 – 2022) con rilevazioni al 31 dicembre, nel Comune di Venezia dal 2004 al 2022, a fronte di una popolazione complessiva in diminuzione che passa da 271.251 persone (31 dicembre del 2004) a 253.174 persone (31 dicembre 2022) con una perdita di 18.077 unità (-6,8%), abbiamo una popolazione in età scolastica dai 0 ai 18 anni relativamente stabile, seppur con segno negativo. Nel 2004 era di 37.033 minorenni, mentre nel 2022 è di 36.828, con un calo di appena 205 unità (-0,55%). Ancora una volta, la presenza straniera (+6.562 unità +387%) passando dalle 1.697 presenze del 2004 alle 8.259 del 2022, ha in gran parte compensato la costante riduzione della popolazione minorile veneziana autoctona ( – 7.077 – 20%) diminuita dalle 35.336 persone del 2004, alle 28.259 del 2022.
Pertanto, se nel 2004 il rapporto tra la popolazione dei minori con cittadinanza italiana e minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio di Venezia era di circa 1 a 12, nel 2022 questo rapporto si è portato a 1 a 4, un rapporto che però non si distribuisce in maniera uguale su tutte le classi d’età e in alcune di queste, soprattutto quelle relative alla scuola d’infanzia, il rapporto è già di 1 a 3.
Nello specifico, prendendo in esame le classi d’età correlate alle fasi di passaggio dei minori nelle scuole dei diversi ordini e grado possiamo constatare come negli ultimi 18 anni, la distribuzione della popolazione minorile straniera per classi d’età scolastica 0-1 sia passata dal 6,9% del 2004 al 33% nel 2022, quella di 3 anni dal 5,2% al 30%, quella di 6 anni dal 4,7% al 28,5%, quella di 10 dal 4,8% al 19,9%, quella di 14 dal 3,5% al 16,7% e infine quella di 18 anni dal 3,7% al 13%. Per queste classi d’età che costituiscono le fasi di passaggio all’interno della carriera scolastica dei minori, l’incremento medio della fascia della popolazione con cittadinanza non italiana in età scolastica da 0 a 9 anni nel periodo 2004 – 2022 è del 23,65%, mentre per quella 10 – 18 anni è del 12,5%.
Questi primi dati sulla popolazione minorile relativi al contesto urbano della città di Venezia, con particolare riferimento alle classi d’età 0 – 18 anni, composta prevalentemente da seconde generazioni (bambini nati in Italia da genitori stranieri), e in misura più limitata da ricongiungimenti familiari e da minori stranieri non accompagnati, stanno ad indicarci che:
1. I minori con cittadinanza non italiana hanno limitato la costante diminuzione della popolazione del comune di Venezia facendo si che la perdita delle 18.077 persone verificatasi in questi ultimi 18 anni sia prevalentemente distribuita nelle classi d’età dai 18 anni in sù, in particolare nella fascia d’eta 25 – 49 anni che nel 2004 era composta da 97.751 persone a fronte delle 68.844 unità registrate del 2022, mentre se consideriamo la fascia d’età 0 – 19 possiamo rilevare che grazie all’incidenza dei minori stranieri, la popolazione è addirittura aumentata passando dalle 49.407 persone registrate nel 2004 alle 51.386 del 2022.
2. Questa popolazione di minori e adolescenti con cittadinanza non italiana per la stretta connessione con l’attuale fenomeno sociale delle migrazioni forzate (è dall’inizio del 2001 che, ogni anno, dalle tre rotte migratorie del mar mediterraneo e dalla rotta terrestre balcanica entrano in Europa all’incirca 350.000/400.000 persone), potrebbe essere destinataria di potenziali svantaggi socio – economico temporanei o strutturali, tali da esporli a marginalità sociali e culturali, nonchè impedire loro di poter soddisfare bisogni, desideri e aspirazioni nei percorsi scolastici, di inclusione sociale, di formazione e inserimento lavorativo, di vita autonoma e autodeterminata.
Per poter rimuovere questi ostacoli le comunità urbane avrebbero la necessità di dotarsi di una strategia di contrasto alla povertà sociale ed educativa affinché i potenziali gap materiali e culturali e le possibili diseguaglianze da questi derivanti, possano essere superati e trasformati in opportunità di crescita. Il futuro delle nostre comunità urbane, attraversate da questa ormai strutturale trasformazione multietnica, dipenderà molto o in gran parte, dalle politiche che le stesse adotteranno nei confronti dei minori e degli adolescenti di origine straniera o mista, siano essi nati o meno in Italia.
Qualora il fenomeno sociale dei minori ed adolescenti con cittadinanza non italiana presenti nei centri urbani non venga tenuto in dovuta considerazione nel dibatitto pubblico nazionale e locale, soprattutto non si traduca, come sembra stia succedendo, in politiche attive di inclusione di tale popolazione, l’impatto di tale fenomeno sulle Istituzioni Scolastiche, Sociali, Sanitarie e Socio-Sanitarie potrebbe mettere in crisi non solo tali Istituzioni come già sta succedendo in molte città del nord Italia, ma la tenuta della convivenza nelle stesse comunità locali.
Gli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola due criticità: Concentrazione e dispersione scolastica
Non avendo a disposizione un osservatorio che integri i dati sia a livello nazionale, regionale che locale sulla presenza dei minori con cittadinanza non italiana e loro impatto in ambito sanitario, socio-sanitario, scolastico e sociale, proviamo ad addentrarci sul settore scolastico che ad oggi sembra essere l’Istituzione in grado di fornire i dati piu sistematici su tale fenomeno.
Nell’ottobre del 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione attraverso l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, elabora un documento dal titolo significativo “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”4.
“La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel plura-lismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della relatività delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativismo assoluto, che postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni”5.
“In termini di riposta positiva e di possibili collaborazioni tra scuola e territorio, segnaliamo tre necessità e attenzioni.
La prima necessità è quella di portare a sistema e di diffondere la conoscenza delle situazioni positive e consolidate, in termini di: modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, vademecum operativi); azioni realizzate; integrazione delle risorse; elaborazione e diffusione di materiali e strumenti; coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie straniere; coinvolgimento dei mediatori culturali, formazione degli operatori e dei docenti. Uno strumento potente di diffusione delle pratiche, delle modalità organizzative della scuola e delle forme della collaborazione interistituzionale è oggi rappresentato dalle reti di scuole, che hanno contribuito fin qui a scambiare esperienze, indicare possibili strade e impostazioni progettuali.
La seconda necessità, che oggi si impone con forza soprattutto in alcune zone e città, è quella di collaborare insieme per prevenire fenomeni di concentrazione delle presenze straniere in una determinata scuola o plesso. L’azione congiunta delle istituzioni scolastiche e del territorio può contribuire a prevenire tali situazioni, o a governarle qualora esse si presentino. Vi sono già esperienze positive in tal senso (protocolli di intesa a livello cittadino) che possono diventare modalità paradigmatiche per altre città e scuole.
La terza necessità, infine, è quella di sottolineare il fatto che l’integrazione scolastica è una parte – importante, ma non esaustiva – dell’integrazione complessiva. Per favorire il processo di inclusione dei minori stranieri nelle città e nelle comunità, la scuola e il territorio devono lavorare in maniera congiunta, fianco a fianco, per far sì che i luoghi comuni diventino davvero luoghi di tutti6”.
Nel 2010 il Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) attraverso il Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, emana la Circolare Ministeriale n. 2 08/01/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana7″.
Nel Paragrafo 2. “Inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana” si riporta: “è indubbio che classi formate da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei – siano essi italiani o stranieri – possono tradursi in un oggettivo fattore di rischio di parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni coinvolti in tali situazioni.
Un’analisi attenta dell’intera questione mette in evidenza alcune criticità che possono così essere riassunte:
a) la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che caratterizza l’itinerario scolastico degli alunni provenienti da un contesto migratorio;
b) la loro conoscenza della lingua italiana, talora assente o padroneggiata a livelli di competenza notevolmente differenti;
c) il possesso della “nuova” lingua più come spontaneo registro utile alla “comunicazione” quotidiana che non come strumento per lo studio nell’ambito dell’itinerario scolastico;
d) la necessità di prevedere, al di là di ogni semplicistica separatezza, anche moduli di apprendimento e percorsi formativi differenziati, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado;
e) la presenza di culture diverse all’interno delle comunità straniere e il loro impatto con la cultura italiana.
Sono elementi questi che costituiscono tutti, anche se in forme non necessariamente omogenee, occasione di adeguata riflessione8”.
Nel paragrafo 3. Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione
delle classi “A fronte delle variabili e delle criticità appena ricordate occorre dare risposte tempestive e congruenti, già nel breve periodo.” “Al riguardo si elencano qui di seguito alcuni punti fermi, che dovranno costituire da quadro di riferimento alle diverse iniziative e operazioni da porre in campo per garantire una partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa.
Tali punti non vanno peraltro intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensì quali criteri di carattere organizzativo sia dell’offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica:
1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.
3. il limite del 30% può essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale – a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all’atto dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all’attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità”9.
La Prof. Roberta Altin in un saggio del 202110 scritto a seguito di una ricerca-intervento realizzata all’interno di un progetto FAMI-Impact (2018-20) coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Riporta nell’Abstract:
“La scuola italiana inizia a rapportarsi con i figli della migrazione a partire dai primi anni ’90 con l’incremento costante dell’immigrazione fino alla crisi economica del 2008 per poi riprendere con altre modalità di ingresso dopo la cosiddetta ‘crisi migratoria’ del 2015. Se nella prima fase la scuola alle prese con i nuovi alunni stranieri adotta prevalentemente un approccio differenzialista che tende a leggere le diversità linguistiche e culturali come ostacoli da affrontare per inserire i corpi estranei nella communitas scolastica, con il passare degli anni le direttive politiche e i processi di governance scolastica scivolano verso altre modalità che in teoria dovrebbero aprire “la via italiana verso la scuola interculturale” (MPI 2007), ma in pratica la rendono ulteriormente meno accogliente e inclusiva. In questo articolo sostengo che la situazione dei migranti nelle scuole sia frutto di due azioni sinergiche e parallele: da un lato il confinamento che enfatizza la visibilità e la separazione degli stranieri a scuola, dall’altro la dispersione scolastica, che espelle i ‘corpi’ estranei nel percorso scolastico, facendone perdere le tracce. L’approccio adottato è quello antropologico, con riflessioni e dati che provengono dall’osservazione sul campo come responsabile scientifica del Centro Interdipartimentale sulle Migrazioni e Cooperazione allo Sviluppo Sostenibile dell’Università di Trieste incaricato nell’ultimo biennio di condurre una ricerca nei contesti scolastici per progettare azioni di contrasto alla dispersione scolastica di alunni/e con background migratorio all’interno di un progetto FAMI-Impact (2018-20) coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia”11.
La prospettiva interculturale adottata dallo stato italiano sembra quindi non trovare applicazione sui territori o quantomeno non risultare ad oggi uno strumento efficace almeno per quanto riguarda l’applicazione del numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe che non dovrebbe di norma superare il 30% del totale degli iscritti, né per quanto riguarda la riduzione dell’incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che sembra caratterizzare l’itinerario scolastico di molti degli alunni provenienti da un contesto migratorio.
I report del Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio di statistica “gli alunni con cittadinanza non italiana” A. S 2019/2020 – A. S 2020/2021”
Il report del Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “gli alunni con cittadinanza non italiana” riporta che nell’A. S 2019/202012” il 10,3% della popolazione scolastica è di origine migratoria, sono 876.801 su 8.484.000 studenti.
Nell’anno scolastico 2020/202113 pur rimanendo inalterato il rapporto tra alunni di cittadinanza italiana e non (10,3%) e un costante calo della popolazione scolastica totale (8.363.000) si registra per la prima volta da quando sono disponibili i dati statistici (1987) anche una diminuzione del numero di studenti di origine migratoria di oltre 11.000 unità rispetto all’anno precedente (865.388).
Nell’anno scolastico 2019/2020 “i tassi di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana sono prossimi a quelli degli italiani nella fascia d’età 6 – 13 anni e nella fascia 14 – 16 anni mentre al contrario a 17 e 18 anni d’età il tasso di scolarità diminuisce fino al 73,2% rispetto all’81,1% degli studenti con cittadinanza italiana”14, di fatto, tra i diciasettenni e i diciottenni “un terzo degli studenti con cittadinanza italiana non realizza una formazione completa per l’inserimento nel mondo del lavoro”. Questi dati sono più o meno confermati nel rapporto dell’A.S. 2020/2021. “A 17-18 anni invece (ultimo biennio di Secondaria di II grado) il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana diminuisce fino al 77,4% rispetto all’83,3% degli studenti italiani”. “Pur tenendo presente che i dati di base utilizzati per il calcolo dei tassi portano a sovrastimare la situazione della scolarità, approfondendo l’argomento del ritardo scolastico nel capitolo 5, è qui da rilevare l’interruzione di frequenza scolastica tra i 17 e i 18 anni che porta quasi un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana a non completare il percorso di istruzione secondaria. L’abbandono scolastico riguarda maggiormente I ragazzi rispetto alle ragazze15”.
Il 64,5% degli studenti con cittadinanza non italiana è rappresentato dalle seconde generazioni, ovvero dagli studenti con cittadinanza non italiana nati in Italia che costituiscono ormai l’unica componente in crescita della popolazione scolastica. “Nell’anno scolastico 2019-2020 gli studenti con cittadinanza non italiana nati all’estero sono diminuiti di oltre 3 mila unità, mentre gli studenti nati in Italia sono aumentati di oltre 22 mila unità. A fronte di un calo di oltre 100 mila studenti italiani, la popolazione scolastica complessiva diminuisce di 95.700 unità16”.
“In Veneto il 71,7% degli studenti di origine straniera è nato in Italia17”. Nell’anno scolastico 2020/2021 le seconde generazioni pur essendo aumentate “di sole 3.226 unità, la quota dei nati in Italia sul totale degli stranieri di origine migratoria si è attestata al 66,7%, un punto in percentuale in più rispetto al 2019/2020 (65,4%)”18.
Concentrazione scolastica
In base alle disposizioni ministeriali del 2010 il numero degli alunni con cittadinanza straniera non deve superare di norma il 30% degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Ma i dati nel 2019/2020 confermano una tendenza all’aumento delle scuole che superano la soglia del 30%. “la scuola dell’infanzia si conferma l’ambito educativo più critico nel senso che in questo settore è elevato il numero di scuole senza bambini stranieri (28,3%) sia quello in cui la presenza di bambini con cittadinanza non italiana supera il 30% (8,4%). Si segnala l’aumento delle scuole in cui gli studenti di origine migratoria rappresentano la maggioranza. Dal 2018/2019 al 2019/2020 le scuole over 50% sono passate da 805 alle 880 di cui oltre la metà sono scuole dell’infanzia. A livello regionale le scuole che superano la soglia del 30% di alunni con cittadinanza non italiana si trovano al nord, in Veneto sono 475 pari al 10,9% del totale”.“Con riferimento alla problematica della concentrazione a livello di classe, i dati segnalano un costante leggero aumento delle classi con oltre il 30% di alunni con cittadinanza non italiana: 6,1% nel 2019/2020 rispetto al 5,9% nel 2018/2019, al 5,6% nel 2017/2018 e al 5,3% nel 2016/2017. Va tenuto conto che i dati comprendono gli studenti di origine migratoria nati in Italia. Escludendo questi alunni, le classi con oltre il 30% di alunni con cittadinanza non italiana nati all’estero si riducono allo 0,5%, con un picco in Piemonte e Friuli V.G. (0,8%).
La scuola Primaria registra la percentuale più elevata di classi con più del 30% di studenti con cittadinanza non italiana (9,5% nel 2019/2020 e nel 2018/2019; 9,0% nel 2017/2018), ma anche la percentuale più bassa quando si considerano solo gli studenti nati all’estero (0,3%).
Al contrario, nella Secondaria di II grado si osserva la percentuale più bassa di classi “over 30%” se si considerano tutti gli studenti con cittadinanza non italiana (2,9%), ma la più elevata se si considerano solo gli studenti nati all’estero (1,0%)19”.
I dati relativi all’anno scolastico 2020-2021 confermano quelli del precedente anno scolastico con un leggero aumento delle sedi con oltre il 30% di alunni con cittadinanza non italiana “sia nella Scuola primaria dove sono il 5,8% del totale (5,7% nel 2019/2020) sia nella Secondaria di II grado con il 4,5% rispetto al 4,4% dell’anno precedente (Graf. 11). Da segnalare l’aumento delle scuole in cui gli studenti di origine migratoria rappresentano la maggioranza. Dal 2018/2019 al 2020/2021 le scuole “over 50%” sono passate da 805 a 859, di cui oltre la metà (503 unità) sono Scuole dell’infanzia. Seguono 275 scuole dell’istruzione primaria e 44 Secondarie di II grado. A livello regionale, le scuole che superano la soglia del 30% di alunni con cittadinanza non italiana si trovano al nord. Le unità scolastiche di questo tipo sono, in valore assoluto, 1.058 in Lombardia (pari al 13,5% delle scuole in regione), 559 in Emilia-Romagna (16,3%) e 463 in Veneto (10,7%); in Liguria la percentuale delle scuole oltre il 30% arriva all’11,4% 20”.
“La Primaria registra la percentuale più elevata di classi con più del 30% di studenti con cittadinanza non italiana (10,6% nel 2020/2021; 9,5% nel 2019/2020 e 2018/2019; 9,0% nel 2017/2018), ma anche la percentuale più bassa quando si considerano solo gli studenti nati all’estero (0,3%).
Al contrario, nella Secondaria di II grado si osserva la percentuale più bassa di classi “over 30%” se si considerano tutti gli studenti con cittadinanza non italiana (3,3%), ma la più elevata, insieme al I grado, se si considerano solo gli studenti nati all’estero (0,9%)21”.
Regolarità, ritardi e abbandoni durante il percorso scolastico
“La regolarità del percorso scolastico è una delle dimensioni di analisi attraverso cui valutare l’integrazione formativa e sociale degli studenti di origine migratoria. Il ritardo degli studenti con cittadinanza non italiana è spesso conseguente a inserimenti in classi inferiori a quelle corrispondenti all’età anagrafica, a cui si aggiungono lungo il percorso i ritardi dovuti alle non ammissioni all’anno di corso successivo. Le informazioni sull’età anagrafica e la classe frequentata permettono di ricostruire un quadro puntuale della situazione.
Nell’A.S. 2020/2021 l’82,7% degli studenti con background migratorio di 10 anni di età frequenta regolarmente la quinta classe di Scuola primaria, il 12,0% ha un anno di ritardo, l’1,3% ha accumulato due anni e oltre di ritardo . A 14 anni, corrispondenti alla frequenza della prima classe di Secondaria di II grado, la percentuale degli studenti di origine migratoria con percorso di studio regolare si ferma al 65,4% mentre il 31,9% frequenta ancora una classe di Secondaria di I grado; il 26,7% è in ritardo di un anno, il 4,6% di due e lo 0,6% di tre anni. All’età di 18 anni la percentuale di studenti regolari scende al 42,5% contro il 57,5% in ritardo: si va dall’1,6% dei diciottenni che frequenta il primo anno di Secondaria di II grado al 33,3% che frequenta il quarto anno. Tra gli studenti di Secondaria di II grado in ritardo si annoverano inoltre circa 35.200 studenti di età 19-20 anni e oltre, di cui il 30,2% si trova ancora al primo o al secondo anno di corso. Il ritardo scolastico colpisce gli studenti più delle studentesse. I dati mostrano che il percorso scolastico delle studentesse è relativamente più regolare rispetto a quello dei ragazzi. All’età di 10 anni le studentesse in ritardo di 1 anno o più sono il 11,3% contro il 15,3% dei ragazzi. All’età di 14 anni le studentesse che frequentano ancora classi di Secondaria I grado sono il 27,7% contro il 45,3% dei maschi. A 18 anni i maschi in ritardo sono il 60,8% e le studentesse il 53,9%”. “Oltre il 35% dei giovani di 18-24 anni è a rischio di abbandono formativo. Una conseguenza allarmante del ritardo scolastico è senz’altro costituita dall’abbandono, come in parte già indicato dai tassi di scolarità per età (vedi Capitolo 1). L’esame di questo fenomeno attraverso l’indicatore europeo degli Early Leaving from Education and Training (ELET) evidenzia che gli alunni con cittadinanza non italiana sono quelli a più alto rischio di abbandono. Nel 2020 l’indicatore ELET riferito agli studenti stranieri è pari al 35,4% a fronte di una media nazionale del 13,1%, a sua volta distante di 3 punti percentuali dall’obiettivo europeo 2020 uguale al 10%”.
La dispersione scolastica nel Comune di Venezia
Non abbiamo la possibilità di reperire dati relativi a regolarità, ritardi e abbandoni dei minori durante il percorso scolastico nella Città di Venezia ma possiamo reperire su internet il “REPORT SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA” anno scolastico 2018/19, Città di Venezia, a cura della Dott.ssa Miatto22. In tale report troviano riportato che relativamente alla popolazione in obbligo scolastico 6 – 16 anni, la percentuale delle segnalazioni relative al fenomeno della dispersione scolastica del territorio i minori coivolti (152) costituiscono l’1% della popolazione scolastica (23.664) E’ un dato che riguarda prevalentemente la componente maschile (97 su un totale di 152 pari al 63,18%), le segnalazioni relative agli studenti italiani riguardano 92 adolescenti pari al 60,53% di quelle totali, mentre per gli studenti di origine migratoria sono 60, il 39,7% del totale. “Se si confronta però il numero delle segnalazioni con quello dei residenti suddivisi per origine si evidenzia come la percentuale delle segnalazioni degli alunni/studenti stranieri sia maggiore.
Confrontando infatti il rapporto ottenuto tra la residenza e la provenienza, si nota che la percentuale riguardante gli alunni/studenti italiani lo 0,47% è circa 1/3 rispetto a quella riguardante gli alunni/studenti stranieri il 1,45%. Rispetto a quanto presentato nel grafico si ritiene utile precisare la composizione di alcuni dati.
• Delle 92 segnalazioni di alunni/studenti italiani, 24 riguardano bambini/ragazzi Rom, Sinti;
• dei 60 alunni/studenti di origine migratoria 26 sono bambini/ragazzi provenienti dal Bangladesh23”.
“Il report evidenzia, inoltre, come la “percentuale degli alunni/studenti di sesso maschile sia maggiore di 5 punti percentuali in quelli di origine migratoria 67% rispetto a quelli di origine italiana 62%24”. Dagli I.C. Grimani, G. Cesare, C. Colombo, L. Da Vinci e dalla C. Baseggio provengono il maggior numero di segnalazioni. Non abbiamo dati sulla percentuale della popolazione con cittadinanza non italiana in questi istituti, ma sicuramente la Grimani e la Cesare Battisti hanno una concentrazione superiore al tetto del 30%25. Infine, relativamente agli alunni di origine straniere “si può notare come la maggior quantità di segnalazioni totali sia dato, anche in questo caso, da un più elevato numero di segnalazioni derivanti dalle scuole secondarie di I grado26”. Per quanto riguarda le segnalazioni di inadempienza nell’a. s. 2018/19 relativamente agli studenti frequentanti scuole secondarie di II grado suddivise per Istituto, possiamo rilevare che sono state 50 in totale e quelle relative agli studenti con cittadinanza non italiana sono in totale 12 “si nota una notevole superiorità numerica di quelle comunicate dall’Istituto Professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “A. Barbarigo”, 18 su 50 segnalazioni complessive, ovvero il 36% del totale; a seguire troviamo le minori, seppur evidenti in termini numerici, segnalazioni arrivate dall’Istituto ENGIM- Veneto Scuola di Formazione Professionale (7 su 50)27”. Interessanti sono le considerazioni conclusive di tale Report “Da quanto riportato si evince come il fenomeno di abbandono scolastico sia presente anche nel nostro Comune, è altresì evidente che un’azione tempestiva e coordinata tra Servizi può incidere positivamente sulla ripresa scolastica dei minori. La possibilità che i ragazzi possano trascorre parte del loro tempo a scuola non è importante solamente per la realizzazione delle potenzialità di ognuno ma anche perché contribuisce a limitare l’emergere di situazioni di possibile rischio legate ad una mancanza di progettualità e di impegno del tempo presente28”. Tra le motivazioni dell’inadempienza scolastica “le più ricorrenti tra i ragazzi di origine migratoria sono una presenza non continuativa nel nostro Paese, con frequenti e prolungati periodi di permanenza all’estero che producono dei vuoti nel processo di apprendimento, demotivazione e scarsa integrazione; a volte il progetto di vita della famiglia di origine viene modificato, anche in relazione alla situazione economica del nucleo, sottovalutando le ricadute che le scelte fatte dai genitori potranno avere sulla carriera scolastica dei figli e più in generale sul loro futuro. In queste situazioni è stata importante la collaborazione con il “Servizio Migrazioni: orientamento, mediazione e integrazione” del Comune per l’accompagnamento delle famiglie e per I percorsi attivati anche a supporto della frequenza scolastica.
Nella generalità delle situazioni affrontate sono emerse anche motivazioni legate alla situazione individuale dei singoli bambini e ragazzi, situazioni di fragilità che sfociano in ansia, fobia scolare e ritiro quando l’ambiente scolastico e sociale è percepito come fortemente stressante e non più sostenibile.
Per sostenere queste realtà si è instaurata una collaborazione con il “Servizio per l’età evolutiva Polo Adolescenti di Mestre e Venezia” dell’ULSS3 Serenissima29”. “Anche la situazione socio-economica della famiglia di provenienza incide sulla scelta di abbandonare la scuola. Per questo si è rivelato importante chiedere la collaborazione e l’intervento dei diversi Servizi della Direzione Coesione Sociale: per rafforzare le competenze genitoriali, sostenere i percorsi di crescita dei minori e intervenire nelle situazioni di bisogno incontrate. Dall’esperienza condotta è emerso in modo chiaro che ogni alunno/studente ha una sua storia, una sua “fisionomia” ed è per questo che l’azione risulta più incisiva se prevede percorsi personalizzati per ogni bambino e ragazzo. Il Servizio di Progettazione Educativa crede fortemente nel compito istituzionale che deve perseguire, nell’importanza di offrire ai minori una nuova possibilità per la ripresa della frequenza scolastica, per questo si attiva per riallacciare i fili che si sono spezzati affinché i ragazzi possano riprendere il percorso di istruzione, perché può rappresentare il presupposto per la realizzazione della loro persona e dunque motivo di arricchimento per tutta la comunità30”.
Associazione Second Generation – Legami e Relazioni Sociali Multiculturali APS
Mestre, 11 agosto 2023
1 XIII RAPPORTO ANNUALE Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia; A cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
2 https://www.comune.venezia.it/it/content/stranieri-residenti-anno-2022
3 https://www.tuttitalia.it/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2004/#google_vignette
4 https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_intercultura.pdf
La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri
Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, Ottobre 2007
5 https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_intercultura.pdf La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri pp 8 – 9 La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri pp 8 – 9
6 https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2007/allegati/pubblicazione_intercultura.pdf La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri pag. 19
8 http://www.integrazionescolastica.it/upload/art916/cm2_10.pdf Pag. 3
9 http://www.integrazionescolastica.it/upload/art916/cm2_10.pdf Pag. 3 – 4
10 Altin Roberta: Contesti multiculturali: problemi, metodi pratiche educative. A cura di Pierpaolo Marrone e Paolo Sorzio, Mimesis/Collana Etica & Politica; pp 71-88
11 https://arts.units.it/handle/11368/2993902
12 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Alunni+con+cittadinanza+non+italiana+2019-2020.pdf/f764ef1c-f5d1-6832-3883-7ebd8e22f7f0?version=1.1&t=1633004501156
13 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/NOTIZIARIO_Stranieri_2021+%281%29.pdf/150d451a-45d2-e26f-9512-338a98c7bb1e?t=1659103036663
14 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2019/2020; Pag. 10
15 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2020/2021; Pag. 12
16 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2019/2020; PGT 18
17 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2019/2020; Pag. 23
18 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2020/2021; Pag. 20 (Tav. 7)
19 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2019/2020; Pag. 36
20 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2020/2021; Pag. 38
21 Ministero dell’Istruzione Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica Ufficio di statistica “GLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA” A.S. 2020/2021; Pag. 38
22 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdfInadempinza Scolastica a.s. 2018-19.pdf
23 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdf pag 9 – 10
24 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdf pag 9 – 11
25 https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-venezia-e-mestre/20180908/281552291747481 “fuga dalle scuole con troppo stranieri”.Il prefetto convoca I presidi.Istituti invitati a collaborare per rispettare I limiti.
26 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdf ; pag 17
27 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdf pag 18
28 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdf pag 25
29 Https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/Report Inadempinza Scolastica a.s. 2018-19.pdf; pag 25
30 https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/Report%20Inadempienza%20Scolastica%20a.s.%202018-19.pdf; pag 25 – 26
